
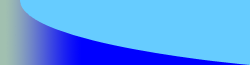
 |
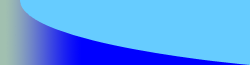 |
Informatica
e Information Technology.
|
|||
|
1) L’informatica medica L’Informatica Medica (IM) è la branca scientifica che si occupa del recupero, immagazzinamento ed uso ottimale di informazioni biomediche, di banche dati e di ogni altra conoscenza utile alla risoluzione di problemi clinici, nei settori della didattica e della ricerca.(1). In altre parole, è lo studio di come viene creata, modellata, distribuita e applicata la scienza medica per mezzo di un set di tecniche e di nuove conoscenze che riguardano la gestione organizzativa dell’informazione; in fondo è lo studio di come ci organizziamo per creare e gestire la sanità. Quattro compiti fondamentali dell’informatica medica secondo Nancy Lorenzi (20) - Produrre strutture per rappresentare dati e conoscen-ze, in modo da poter visualizzare relazioni complesse - Sviluppare metodologie per l’acquisizione e la presen-tazione dei dati, in modo da evitare il sovraccarico per l’utilizzatore - Gestire il cambiamento tra le persone, i processi e la tecnologia dell’informazione, in modo da ottimizzare l’utilizzo delle informazioni - Integrare le informazioni da diverse sorgenti per ottenere più della somma delle parti, e integrare le infor-mazioni in applicazioni, in modo che possano essere usate quando producono la massima efficacia Trova vastissime applicazioni:dalla costruzione di sistemi di supporto decisionale per i medici di base, allo sviluppo di strumenti computerizzati per la ricerca, in tutte le specialità e a tutti i livelli della prestazione sanitaria.In alcune università e grandi ospedali sono stati addirittura istituiti dipartimenti specifici, di importanza strategica, sotto il controllo diretto della direzione medica. Soprattutto negli Stati Uniti ed Australia vi sono riviste proprie, organizzazioni e scuole dedicate, con insegnamenti universitari e corsi di perfezionamento. Attraverso l’IM viene potenziata la nostra capacità di descrivere e manipolare le conoscenze mediche ad un livello altamente teorico-astratto, come pure l’abilità di implementare efficienti sistemi di comunicazioni (2). Invece dei farmaci, radiografie, strumenti chirurgici,gli strumenti della IM sono piuttosto le linee guida, i linguaggi medici formali, i sistemi informativi ed i sistemi di comunicazioni (con le reti). L’IM medica fo rnisce quindi i mezzi per la generazione, l ’ analisi, la valutazione e la rielaborazione dei dati e delle risorse della s a n i t à . In part i c o l a re fornisce i concetti essenziali, i metodi e gli strumenti per fa cilitare la discussione-confronto basata sull’evidenza clinica tra i vari attori della scena sanitaria, generando così una conoscenza medica valida e una scelta razionale negli atti ed applicazioni mediche conseguenti. L’IM si avvale di contributi provenienti da campi diversi, a partire dalla fisica, dall’elettronica, dalle scienze delle comunicazioni e delle informazioni, dalla pedagogia, dall’informatica, dalle scienze cognitive, dalla logica, dalle scienze bibliotecarie e da quelle economico-amministrative. La sua crescita è legata fondamentalmente alla scienza computeristica, che permette la digitalizzazione dei dati e la loro successiva e comoda processazione; i grandi progressi nelle telecomunicazioni ne hanno poi amplificato l’utilizzo(3). L’informatizzazione dei settori della sanità è iniziata negli anni Cinquanta; la sua crescente importanza è testimoniata dalla frequenza sempre più elevata con cui il termine Information Technology (IT) appare nella MedLine, con 570 citazioni nel ‘70, 2657 nel ‘90, 5197 nel ’96, 8443 nel 2000 e 9435 nel 2001. Le tappe fondamentali nella storia della I.T. sono state l’automazione dell’Index Medicus, con l’uso del sistema Medlars nel 1964, e lo sviluppo di sistemi informatizzati ospedalieri tra gli anni Sessanta e Settanta; via via si sono affacciati sempre più nella pratica clinica i computer, le apparecchiature biomedicali implementate, le applicazione di telemedicina e le reti, tra cui Internet . I pilastri su cui si appoggia questa particolare specialità sono la computeristica, la telemedicina e il trattamento elettronico delle informazioni scientifiche e della letteratura. In parecchie applicazioni essi si sovrappongono come nel caso di Internet. La computeristica trova applicazioni nei settori: - amministrativi: dall’invio dei pazienti, alla gestione degli appuntamenti,alle pratiche amministrative e contabili,all’elaborazione statistica (tutte le applicazioni di segreteria, compresa la refertazione,invio elettronico dei referti, archiviazione dell’esame); - specialistici: database di pazienti,database di patologia, programmi e software della disciplina, sistemi esperti per diagnosi, terapia, e la gestione delle risorse farmaceutiche; - relativi agli esami: la digitalizzazione dei segnali, il confronto più o meno automatizzato con un database di referenze, l’elaborazione dei risultati e la refertazione assistita, gli help in linea. Sul versante del paziente sono le smart card sanitarie, la gestione elettronica delle cartelle e dei dati dei pazienti arrivando ad un sistema completo di EMC (electronic medical record). Le applicazioni di telemedicina sono forse le più innovative: comprendono operazioni di telemonitoraggio, di teleconsulto, di una efficiente comunicazione in rete per laboratori satelliti, di discussioni a distanza, di supporti per la didattica remota, per le teleconferenze e in particolare videoconferenze(14). Purtroppo le (nostre) Reti Ethernet e TokenRing sono obsolete perché insufficienti a sostenere la richiesta di incremento di banda e di breve delay richiesto per i servizi di comunicazioni interattive. Le nuove tecnologie si affidano alle comunicazioni in fibra ottica, alle reti Ethernet commutate e soprattutto alle tecnologie ATM e comprendono reti interne, Intranet, LAN e Internet con soluzioni basate su ISDN e ADSL. A sua volta il trattamento dell’informazione elettronica si distingue in recupero della letteratura, distillazione finalizzata di dati e informazioni, costruzione di data base personalizzati, e le cosiddette applicazioni intelligenti con implementazione basate su pro-tocolli. I documenti destinati alla disseminazione del sapere medico trovano la loro miglior espressione nel formato ipertestuale e multimediale; ormai è assodato che, in termini di apprendimento,il massimo vantaggio si ha con i documenti in formato HTML (lo standard Internet di Word Wide Web), dimostratosi sperimentalmente superiore ai documenti testuali semplici con codici ascii e in formato tipografico comune. Per queste conoscenze scientifiche abbiamo a disposizione:banche dati in cdrom, archivio personale, o condiviso,di tavole anatomiche, di metodiche, di protocolli, di valori di referenza, supporti elettronici educativi e didattici con ampie opzioni per la information retrieval. È comunque difficile gestire la massa di informazioni mediche che cambiano, si aggiornano e soprattutto crescono vertiginosamente. Alla fine del 2000 vi sono più di 11 milioni di citazioni del Medline attinte da 4300 riviste e con circa 32.000 citazioni aggiunte ogni mese(4). Ancor adesso purtroppo non abbiamo validi sistemi di recupero assistito delle informazioni, specialmente quelle in rete. I vari tools presentano finora avanzate opzioni pratico-tecnologiche più che teorico-metodologiche. Sono però allo studio progetti pilota come il WAX Active Library a Cambridge, con un sistema software per eliminare l’overload sulla scrivania del medico di base e per assicurare che importanti informazioni siano accessibili nel tempo giusto (usualmente entro 15 sec.), nella forma corretta, senza creare un’altra montagna di documenti, questa volta virtuali(5). Sono stati già proposti anche sistemi semplici ed efficaci (user friendly) che abbiano l’opzione di catalogare i documenti in ordine di importanza per le decisioni cliniche con una serie di precedenze (per le lineeguida, le rassegne sistematiche, gli studi controllati). 2) COMUNICATION TECHNOLOGY Le nuove tecnologie basate sui computer e applicate alle comunicazioni hanno fornito strumenti formidabili per il recupero, la fruizione e lo scambio di informazioni di interesse professionale. La telematica - un neologismo creato attraverso la fusione di due parole : telecomunicazione e informatica - si interessa dell’uso delle tecnologie informatiche nel campo delle telecomunicazioni ; applicazioni telematiche sono ad esempio gli sportelli Bancomat , i fax e i terminali per la prenotazione di visite in ospedale. Le reti telematiche connettono fra loro più computer, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, etc (6). I vantaggi del collegamento attraverso questo tipo di reti sono molteplici, dalla possibilità di far transitare velocemente grandi quantità di dati, alla possibilità di accedere alle risorse informative residenti su altri computer o di utilizzare periferiche, come stampanti o fax, collegate ad altri elaboratori, e così via. 2.1 Reti locali e reti su territorio Esistono vari tipi di rete, dalle più piccole, che possono essere composte anche solo da due personal computer, a reti enormi, con migliaia di computer, distribuite su vaste aree geografiche.Le reti di primo tipo,dette LAN (Local Area Network), realizzate cioè in sede locale – tipicamente all’interno di uno stesso edificio e magari di una struttura ospedaliera - nascono nella maggioranza dei casi per un uso d’ufficio (condivisione di periferiche, scambio di messaggi tra un piano e l’altro, etc.) e spesso non permettono alcun tipo di accesso dall’esterno. Le reti MAN, acronimo per Metropolitan Area Network, servono un’area di alcuni chilometri (fino ad una decina), quindi una zona comunque limitata. Attraversando strutture abitate e suolo pubblico urbanizzato utilizzano mezzi trasmissivi analoghi a quelli usati nelle ampie reti geografiche, ma con criteri topografici e organizzativi analoghi a quelli delle reti locali.Ne sono un esempio le reti civiche che la maggior parte dei grandi comuni possiede (le cosiddette reti civiche metropolitane), oppure la rete di un gruppo di ospedali cittadini che fanno parte della stessa organizzazione sanitaria. Se si utilizzano le nuove tecnologie, le velocità di trasmissione delle MAN possono essere molto elevate, fino a 100 Mbit/s. Le reti più vaste, dette geografiche o WAN (Wide Area Network), connettono computer spesso assai distanti l’uno dall’altro, ad esempio le varie sedi di una multinazionale(7). Queste reti sono, per loro stessa natura, molto più “aperte” delle reti locali, hanno cioè già predisposte tutta una serie di procedure per accogliere nuovi elaboratori remoti: da quelli di una eventuale nuova sede, fino al computer portatile di un dipendente munito di modem e, ovviamente, linea telefonica. 2.2 Dalla reti locali ad Internet Le reti appena descritte possono avere topologie differenti. Il modello Client/server è senza dubbio uno dei più diffusi. In esso, il client è un computer “stupido”, che ha solo una funzio-ne di immissione di dati, mentre il server è costituito da una unità più potente che contiene programmi e applicazioni pesanti, è in grado di svolgere funzioni di programmazione e archiviazione e può ospitare grandi volumi di dati. Le reti tendono sempre di più a connettersi l’una con l’altra, abbracciando fra le loro ‘ maglie ’ tutto il mondo. Le reti nazionali diventano parte delle reti continentali e queste delle reti mondiali. Per Intranet si designa una rete di computer basate sulle tecnologie di Internet e del WWW, il cui scopo è però limitato alle comunicazioni all’interno di una organizzazione (una sorta di Internet privata). Una Intranet può, al bisogno,essere connessa ad Internet ed ad altre Intranet : molti ospedali e grosse organizzazioni sanitarie possiedono una propria Intranet che ha il vantaggio di riservatezza, sicurezza, velocità molto maggiori e spese di collegamento molto minori di Internet. Per Extranet si inten-de una tipologia di reti con tecnologia TCP/IP il cui scopo è connettere fra di loro le reti locali di diverse aziende o istituti. Le reti Extranet non sono di solito liberamente accessibili dagli Utenti Internet:la tecnologia usata è la stessa,ma lo scambio di informazioni è limitato ai soli Utenti autorizzati.
Firewall Il Firewall (mangiafuoco) è un meccanismo hardware o software che permette di impostare restrizioni a uno o più computer collegati a Internet;in altre parole, è un sottosistema che viene interposto tra una rete aziendale interna (tipicamente Intranet) ed Internet per controllare appropriatamente i dati di accesso, con funzioni di protezione e di sicurezza. Lo scopo è quello di salvaguardare i dati interni, limitare l’accesso esterno -per esempio dei pirati informatici- e fornire un accesso remoto sicuro agli Utenti aziendali che lavorano sul territorio. Questo sistema di sicurezza è particolarmente utilizzato per la protezione delle reti ospedaliere che contengono dati riservati e, nello stesso tempo, utilizzano la rete per accessi esterni servendosi degli stessi terminali. 2.3 Presente e futuro delle reti telematiche Le reti, abbiamo visto, possono connettere tra loro più computer utilizzando mezzi diversi, che ne determ inano , di fatto, la capacità (quantità di informazioni/ tempo). La dorsale italiana, che pure sta cercando di mettersi al passo con quella di altri Paesi con il cablaggio delle città, è per buona parte ancora vetusta, con velocità di trasmissione dati pari a 3,5 Mbps. Fortunatamente è prevedibile, a medio termine , l’utilizzo di larghe bande e di metodologie di comunicazione molto veloci, tali da permettere un radicale cambiamento dell’attività medica che coinvolgerà , ovviamente, anche lo specialista neurologo. Utilizzando i cavi e le apparecchiature presenti già in tutti gli uffici, ambulatori ed ospedali,e cioè le linee telefoniche e, presto, la televisione via cavo sfrutteremo la possibilità delle Digital Subscriber Lines (DSL) di suddividere la banda del telefono in una porzione ad alta frequenza -da utilizzare per la connettività Internet ad alta velocità (almeno dieci volte più veloce delle connessione attuale a 56 Kbps), e una porzione a bassa frequenza- che servirà per la linea telefonica vocale convenzionale e la trasmissione con fax-modem. I modem utilizzati per i cavi dedicati alla TV permettono una velocità analoga al DSL. Una volta che sarà disponibile diffusamente la nuova dorsale a larga banda veloce della Next Generation Internet, sarà possibile utilizzare nell’attività di tutti i giorni la trasmissione audio e video interamente basata su Internet. Questo rivoluzionerà certamente molte applicazioni mediche, ed in particolare la telemedicina,e permetterà al Word Wide Web di evolvere da un modello basato su testi-immagini,a carattere giornalistico,a una forma originale, a forte carattere interattivo. All’estero l’ottimizzazione delle procedure di comunicazione attraverso le reti è iniziato con l’utilizzo delle tecnologie ATM (acronimo per asynchronus transfer mode), che sfruttano un protocollo trasmissivo particolare, applicabile ad ogni tipo di supporto, tra cui le nuove reti a larga banda B-ISDN. Purtroppo, questa nuova tecnologia, molto promettente perché estremamente veloce, non è ancora stata efficacemente implementata in Italia.Essa è invece utilizzata oltreoceano in campo neurologico quale supporto per il telemonitoraggio dei dati neurofisiologici tra le sale operatorie neurochirurgiche e le consolle dei servizi di neurofisiologia in ospedali di una stessa città. L’ambizioso obiettivo della tecnologia ATM è quello di riunire in un’unica struttura portante il trasporto di qualsiasi tipologia di traffico, dalla telefonia, ai dati, dal video fino ad applicazioni future. 3) Gli standard in informatica Il problema dello standard della IT è uno degli scogli che minaccia lo sviluppo delle applicazioni informatiche in medicina. Oggi molti pazienti hanno una lunga lista di documenti elettronici riguardante la loro salute:la cartella del medico di medicina generale, gli esami di laboratorio,le immagini diagnostiche, molti test specialistici e l’eventuale lettera di dimissione ospedaliera. Purtroppo,tali dati e informazioni, raccolti facilmente in digitale, risultano settorializzati, non essendo integrabili o leggibili da diverse strumentazioni, magari per la mancanza di infrastrutture di comunicazione tra loro connesse.Pur ricostruibili e trasferibili su analoga piattaforma informatica, questi documenti non sono accessibili da tutti gli altri sanitari che intervengono sul paziente, proprio perché la documentazione raccolta risiede in tanti sistemi informativi, indipendenti l’uno dall’altro. L’ostacolo principale, quindi, è proprio la mancanza di uno standard unico;le diverse tipologie dei prodotti informatici presenti nel mondo sanitario,la rapidità degli sviluppi tecnologici, il carattere spontaneo delle innovazioni in informatica, la loro immissione disordinata, la difficoltà ad accordarsi tra i vari costruttori,la mancanza di preveggenza dei responsabili tecnici degli ospedali ed infine il disinteresse da parte dei medici, hanno tutti concorso a questo empasse. Con uno standard comune, i laboratori necessiterebbero di un solo database e di un unico generatore di referti (o programma di videoscrittura), indipendentemente del tipo di apparecchiatura.In questo modo il referto potrebbe essere lo stesso anche nel caso di un esame fatto i tempi diversi con macchine differenti o,addirittura,nel caso in cui in un laboratorio venisse introdotta un nuovo tipo di apparecchiatura. La ricerca di uno standard e l’accordo circa il suo utilizzo sono ancora più cruciali nel caso in cui si vogliano rielaborare le informazioni ricevute da diverse fonti,armonizzandone gli elementi (risorse locali,le Reti Intranet e/o locali,Internet) e utilizzando varie tecnologie di comunicazioni, protocolli diversi, diversi sistemi di commutazione e di filtraggio (8). L’adozione di uno standard permette il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, irrinunciabili nell’era della telematica e della globalizzazione: • il controllo remoto - anche ongoing - degli esami eseguiti da operatori di una stessa organizzazione; • la condivisione e la visualizzazione di test e documentazione di un dato paziente; • l’implementazione di una consulenza o un di un forum di discussione; • il corredo iconografico universale per la didattica e le attività di convegni-congressi; • la realizzazione di studi e collaborazioni internazionali per trial, studi normativi, nuove tecniche, lineeguida,etc. Scendendo in esempi, sarà possibile esaminare un paziente presso un ambulatorio periferico e inviare i risultati delle anali-si al centro specializzato per la visione e la definizione della diagnosi. Non viene ad essere più necessaria la presenza del medico specialista presso l’unità periferica, ma è sufficiente che vi sia solo un operatore specializzato per l’acquisizione del referto medico. L’esame è quindi trasferito al centro specializzato dove il medico responsabile compierà la visione ed eventualmente si metterà in contatto con l’ambulatorio periferico per eventuali ulteriori accertamenti. Anche nei sistemi di telemedicina (9) è quindi necessario che la strumentazione elettromedicale fornisca l’esame in formato elettronico digitale compatibile con quella utilizzata in sede centrale. L’informazione potrà essere una immagine bitmap (GIF, BMP, JPG, etc…), un grafico vettoriale (PostScript, HP-GL, etc…) o, meglio ancora, con un formato compatibile DICOM se si tratta di una immagine. Anche formati standard presi dal mondo WEB come l’HTML o dall’editoria come il PDF si stanno affermando prepotentemente come pure il principale program-ma di zippaggio “winzip”, usato per ridurre la dimensione dei file da trasmettere. Tutti questi standard non necessitano del consenso tra i costruttori perché si sono già affermati e probabilmente sopravviveranno per lungo tempo. D’altra parte l’esperienza insegna che, come nelle telecomunicazioni, spesso un linguaggio prende il sopravvento senza accordi precisi e diventa uno standard cui tutti i costruttori devono adeguarsi.In fondo la migrazione verso ambienti comuni, come Windows, l’utilizzo di formati grafici compressi, e di standard di codifica medica come HL7 (10) fortunatamente stanno divenendo già una realtà. La definizione di uno standard internazionale per i dati generati dagli strumenti richiede che ci sia,a monte, una terminologia medica comune e che i test vengano acquisiti e descritti con la stessa modalità e gli stessi termini; infine, che le varie scuole abbiano un accordo sulle tecniche utilizzate, sui valori di riferimento, sulla definizione dei segnali misurati. Il primo ostacolo per un linguaggio comune e l’integrazione dei documenti medici non è quello tecnologico, ma quello legato proprio alla estrema variabilità della terminologia medica:la comunicazione non ambigua di concetti medici complessi e dettagliati è oggi una caratteristica cruciale dei sistemi informativi clinici. Nel campo della ric erca bibliografica e nell’accesso ai documenti scientifici si sta lavorando alacremente, soprattutto da parte della National Library of Medicine su un linguaggio unificato medico (UMLS) (11) mentre l’utilizzo di un tesauro medico controllato quale il MESH è adottato non solo da MedLine, ma anche da siti indicizzatori medici come CliniWEB. Nel campo dei metadati sui documenti elettronici, cioè nella opzione di poter già accedere a delle informazioni nelle informazioni, è prevedibile che il linguaggio XML possa divenire effettivamente uno standard nel giro di un paio di anni (12). Anche in vari settori delle neuroscienze si sta dibattendo il tema degli standard. Nell’ambito neuroradiologico fortunatamente si è già a buon punto grazie al formato DICOM III, emerso come standard pratico, orientato sia per l’oggetto che per client-server, per la trasmissione di immagini e informazioni correlate: può essere importante per le angiografie. Nell’ambito neurosonologico, in particolare per l’ecodoppler dei tronchi sopraaortici, è teoricamente possibile salvare le immagini e il video sempre con lo standard DICOM III e l’utilizzo poi di MJPG. In campo neurofisiologico, è stato possibile sviluppare un programma di conversione dei vari formati di elettroencefalogramma: per la poligrafia si sta affermando faticosamente il formato europeo EDF (13); l’elettromiografia peraltro non ha ancora visto l’accordo internazionale su di un formato di generazione o di scambio comune, che superi lo scoglio dei formati proprietari in diversi tipi di elettromiografi. Ancora, in riabilitazione l’analisi cinematica e poligrafica del movimento richiede l’adozione di standard di registrazione e la leggibilità su piattaforme diverse (ma su cui predomina ora nettamente l’ambiente Windows). In conclusione, le neuroscienze comprendono molti settori in cui le implementazioni informatiche giocano un ruolo importante per un vivace sviluppo.Medici e società scientifiche devono pressare la controparte tecnica e commerciale per l’adozione di linguaggi,sistemi o ambienti operativi,piattaforme software, e sistemi di trasmissione standardizzati, pena l’esclusione dai grandi vantaggi della informatica e telematica. Il linguaggio XML, che supporta ampiamente la multimedialità e la diversità della strutturazione dei dati biologici raccolti dalle nostre apparecchiature, è appena entrato nei discorsi dei neurologi, ma porta con sé grandi promesse. 4) applicazioni informatiche Le tecniche informatiche offrono quindi le basi scientifiche per tutti i documenti medici elettronici. Un sistema di documentazione elettronica clinica basata su Internet e completamente implementata per dialogare con altri sistemi serve come via finale comune per incorporare in modo efficiente tutte le procedure mediche in una ottica basata sulle razionalità e sulle prove di efficacia e per una gestione pratica efficiente volta alla cura dei pazienti nelle varie sedi di erogazione dei servizi. L’informatica è sempre più importante e ampiamente usata nella medicina moderna per più fattori : la quantità, la diversità e la complessità dei dati biologici e biomedici sono enormi e non possono essere ben integrati e valutati senza soluzioni informatiche. Gli strumenti informatici stanno divenendo sempre più potenti e facili da usare(14). L’uso di strumenti e approcci basati sull’informatica, spesso nell’ambiente WWW o con la posta elettronica, sono divenuti una via finale comune ormai accettata per interagire con dati e persone sia nelle scienze di base che nella pratica clinica. Al suo sviluppo ha contribuito il costo decrescente dei computer e delle tecnologie computeristiche, la richiesta di management sanitario indirizzato all’efficienza e alla politica di budget, l’ aumentata specializzazione delle figure sanitarie e le esigenze dei pazienti, che necessitano di una più pronta ed efficiente comunicazione di dati. Di fatto, in Italia le potenzialità della I.M. sono ancora solo parzialmente sfruttate. E questo, prima di tutto, per una questione pratica, legata al tipo di strutture di cui disponiamo. Ci attendiamo, per il futuro, la presenza di una rete di “ invisible computing” cioè una rete ubiquitaria di sistemi e apparecchiature di informazioni - comunicazioni senza filo, tascabili, o forse anche impiantabili , magari provvisti di una interfaccia per il controllo vocale e sempre abilitati e pronti per la connessione(15). 5) Applicazioni avanzate e Sistemi esperti L’informatica medica ha le sue applicazioni più avanzate nell’ambito della cosidetta intelligenza artificiale (AI). Da sistemi e strumenti più semplici quali i sistemi computerizzati per facilitare la diagnosi e la terapia e dai sistemi basati su protocolli, arriviamo a sistemi complessi per il supporto decisionale (DSS) e al machine learning.(16) I sistemi intelligenti, per molti sinonimo di Sistemi Esperti, sul presupposto di una certa comprensione della situazione, hanno una qualche capacità di acquisire conoscenze mediche e quindi di utilizzarle per il ragionamento.Le reti neurali sono programmi computerizzati la cui funzione è basata sul modello di un semplice neurone: queste reti sono composte da strati di neuroni (o nodi) che hanno connessioni con altri nodi in ogni strato: il neurologo ritrova in questi nuovi strumenti molte analogie con i concetti di fisiologia nervosa ben conosciuti. Tali sistemi computerizzati saranno in grado di diagnosticare pattern patologici complessi e potranno avere anche dei dispositivi terapeutici autonomi partendo da una serie di monitoraggi, da dati, informazioni e poi conoscenze contenuti nel sistema che ruota attorno alla cartella clinica elettronica: queste macchine interpretative intelligenti, in grado di aiutarci a prendere decisioni diagnostiche ma soprattutto terapeutiche appariranno non solo come sistemi incorporati all’interno di strumenti, ma anche come entità esplicite capaci di interagire con il medico.(17) Un utilizzo particolarmente interessante dei sistemi esperti, che comprendono anche i learning systems (macchine in grado di apprendere) è quello che viene applicato alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci. Le Reti neurali L’integrazione dei microprocessori su chip di silicio è destinata a collassare entro qualche anno. Soluzioni alternative sono le reti neurali che utilizzano tutte le risorse della matematica e informatica con recenti metodi di calcolo e valutazione. Sono sistemi che simulano i circuiti neuronali del cervello e il loro modo di gestire e distribuire le informazioni. Sono stati progettati come strutture reticolari delle cellule nervose, che sviluppano capacità di apprendimento e sono in grado di imparare a svolgere funzioni per le quali non sono state direttamente programmate. Si parla di progettare sistemi neurali con 10 miliardi di componenti, ma è chiaro che siamo ancora molto lontani dalla complessità del cer vello umano. Nate come modello funzionale delle reti neurali biologiche, le reti neurali artificiali si sono dimostrate strumenti molto utili nell’ambito delle classificazioni di oggetti a morfologia complessa, tra cui l’EEG, ove i parametri utilizzati sono molteplici e non sempre ben determinabili a priori, in quanto correlati da criteri di similitudine. Le reti neurali artificiali, una volta istruite presentando a loro i dati delle misure di tracciati presi come esempi,sono in grado di riconoscere e classificare ogni pattern grafico sugli altri tracciati con velocità, costanza e precisione decisamente superiori a quelle ottenibili con la valutazione ad occhio, per quanto esperto esso sia. Partendo dalla quantizzazione suddetta del segnale EEG, si può arrivare alla sua classificazione automatica, che consiste nell’individuazione dei tratti di tracciato normale od alterato e, nell’ambito di quest’ultimo, ad una ulteriore suddivisione in diverse categorie, similmente a quanto si fa di norma con la valutazione visiva diretta. Le tecniche di “machine learning” hanno dimostrato di eguagliare, se non superare, le analisi statistiche di attività con sviluppo analogico attualmente in uso, con la possibilità in più di generare conoscenze in una modalità che è più facilmente capita dai chimici. Anche lo sviluppo delle linee guida possono essere grandemente aiutate dal machine learning. Spesso ci sono parecchi trattamenti alternativi per una data condizione con outcome lievemente differenti; tuttavia, può non essere chiaro quali caratteristiche di un particolare trattamento sono responsabili dei migliori risultati. Se si strutturano dei database degli outcome dei trattamenti diversi, i sistemi di machine learning possono essere usati per identificare gli elementi che sono responsabili dei diversi outcome. Una applicazione già sperimentata è quella del monitoraggio della farmacoterapia in una corsia ospedaliera, con particolare riguardo agli effetti collaterali e alle interazioni dei farmaci; si sfrutta la possibilità di richiami e avvertimenti con cui il sistema automaticamente allerta l’équipe medica o infermieristica(18). Applicazioni nel campo neurologico vanno dal training strutturato basato su computer sull’interpretazione di immagini neuroradiologiche, a ricerche per l’integrazione di dati multidisciplinari dei sistemi sensoriali, a modelli per decisione di intervento per neurochirurghi e infine alla citata diagnostica neurofisiologica. LE OTTO ABILITÀ CLINICHE INFORMATICHE ESSENZIALI (19) Essere in grado di lavorare con programmi di videoscrittura, per le presentazioni elettroniche, per i fogli di calcolo e per la gestione delle immagini Essere autonomi nel fare un ricerca sulle banche dati mediche in CDROM e su Internet Aver esperienza di lavoro con la cartella clinica elettronica e i sistemi di supporto decisionale basati su computer Aver conoscenza dei sistemi informativi e della rete della propria organizzazione sanitaria Essere in grado di selezionare ed utilizzare i metodi di comunicazione più appropriati per un determinato compito ( es.: conversazione faccia a faccia, telefono, e-mail, video, posta vocale, lettera) Essere capace di mantenere aggiornate una propria conoscenza personale e tecniche relative pur coscienti della natura dinamica e incerta del sapere medico Diventare esperto nel ricercare e nel valutare le conoscenze nell’ottica delle basi statistiche della evidenza scientifica Riuscire a capire bene alcuni dei modelli logici e statistici del processo diagnostico BIBLIOGRAFIA (1)Van Bemmel J Musen MA (1997) Handbook on Medical Informatic Springer Verlag New York (2)Jadad AR,Enkin M (2000) The new alchemy:trasmuting information to knowledge in an electronic age. Can Med Ass J Jun 27;162(13):1826-8. (3)The use of Information Technology in improving medical performances. Gwande AA,Bates DW (2000) h t t p : / / m e d s c a p e . c o m / M e d s c a p e / ge n e r. . . n 0 1 / m g m 0 2 1 4 . g awa / p n t -mgm0214. gawa.html visitato 6-11-00 (4)Hunt DL, Jaeschke R, McKibbon KA (2000) Users’guides to the medi-cal literature. JAMA 283:(14)1875-1879 (5)WAX ACTIVE LIBRARY http://www.waxinfo.com/wax.html visitato 8-1-01 (6)Calvo M, Ciotti F, Roncaglia G, Zela M (1999) Internet 2000; manuale per l’uso della rete. Editori Laterza (7)M i c rosoft Pro fessional Editions (1998) Dizionario di Info rm a t i c a . Mondadori Informatica,Milano (8) 286127Lewers DT (2000) AMA will help you harness information technology. www.ama-assn.org/sci pubs/amnews/amn_00/edca11066.html (9 )Grigsby J, Sanders JH (1998 ) Telemedicine:where it is and where it’s going. Ann Intern Med 129(2):123- visitato 2-1-01 (10) Health Level 7 www.hl7.org/ visitato 10-1-01 (11) Unified Medical Language System http://umls.nlm.nih.gov/ visitato 8-1-01 (12) Extensible Markup Language www.w3.org/XML/ visitato 8-1-01 (13) EDF FORMAT www.medfac.leidenuniv.nl/neurology/knf/kemp/edf/edf.htm visitato 10-1-01 (14) Coiera E (2000) When conversation is better than computation. J Am Med InformAss 7:277-286 (15) Norman DA (1998).: The invisible computer. Cambridge, MA: MIT Press. (16) King RD et al (1992) Drug design by machine learning: the use of inductive logic programming to model the structure-activity. Proc Natl Acad Sci USA 89:11322-11326 (17) Coiera E (1999) Guida all’Informatica Medica –Internet e telemedicina. Il Pensiero Scientifico Editore,Torino (18) Berner ES (1999) Clinical Decision Support Systems : Theory and Practice Springer Verlag New York (19) Coiera E : Medical Informatics meets medical education Med J Aust 1998, 168(7) 319-20 (20) Lorenzi NM (2000) The cornerstones of Medical Informatics J Am Med InformAss 7:204-205
|
|||
Pubblicazione su Indicemedico: Maggio
2001
|