
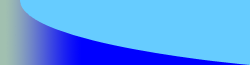
 |
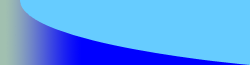 |
Le biblioteche ed il bibliotecario nella società dell'informazione.Maria
Cristina Bassi
|
|||
|
Nella
società odierna – denominata Società dell’Informazione –
l’economia si basa largamente sulla produzione di servizi, sul
settore terziario in cui si manipolano informazioni e sul valore
economico della conoscenza come risorsa strategica. Rispetto al
passato, infatti, oggi si fa un uso enormemente più ampio
dell’informazione, e questa – grazie alla moltiplicazione dei
mezzi di comunicazione – viene trasmessa molto più velocemente. La
ricchezza di nazioni e di gruppi si misura oggi non solo in termini di
merci di tipo tradizionale, ma di accumulo informativo, di possibilità
di accesso alle notizie e di capacità di gestirle e utilizzarle.
L’Information and Communication Technology (ICT) realizza con gli anni Novanta un forte salto di qualità: è in atto un abbattimento dei costi di trasmissione dell’informazione, i cui effetti appaiono ben più dirompenti e pervasivi rispetto alla prima ondata degli anni Settanta-Ottanta (quando a cadere furono i costi di registrazione e di elaborazione dell’informazione). Oggi la tecnologia digitale è in grado di rappresentare, archiviare, riprodurre e trasmettere forme, colori e suoni di qualsiasi tipo ed Internet è entrata a far parte della vita quotidiana di milioni di persone. La Rete, poi, non è che una pallida idea delle cosiddette autostrade dell’informazione che collegheranno in futuro gli individui del pianeta! In quest’epoca di trasformazione, tra le varie istituzioni chiamate a diffondere informazione al cittadino (e non più solo allo studioso e all’impresa) le biblioteche si trovano più che mai coinvolte con grandi opportunità e grandi pericoli. Per il futuro della democrazia è importantissimo assicurare il libero accesso all’informazione locale e remota e alla conoscenza; e poiché il pubblico accesso all’informazione e alla conoscenza è la missione delle biblioteche, esse sono un presidio delle libertà civili di tutti i cittadini, per evitare che le tecnologie dell’informazione portino nuove disparità sociali. Ovviamente ciò sarà possibile se le biblioteche sapranno cogliere la sfida delle nuove tecnologie. Ma quali sono state le specifiche applicazioni delle evoluzioni tecnologiche nelle biblioteche? 1. le basi dati on-line, attraverso cui si possono fare ricerche bibliografiche usando gli operatori booleani (AND OR NOT); 2. le reti di biblioteche, che costituiscono una rivoluzione perché ogni biblioteca diventa una finestra aperta sulle altre aumentando la potenza informativa; 3. la catalogazione derivata e quella partecipata; 4. l’evoluzione del prestito interbibliotecario (Inter Library Loan), che si può effettuare con estrema facilità attraverso messaggi di prestito tra biblioteche; 5. la fornitura di documenti o document delivery e il document supply (il DD elettronico): il primo dei due termini nacque negli anni Settanta, il secondo negli anni Novanta e nell’ambito digitale in cui si stanno evolvendo servizi più personalizzati (quelli detti di contents: per esempio Current Contents, Current Awareness Services e Individual Article Supply) che permettono alle biblioteche di dare accesso ad un utente specializzato. Oggi l’obiettivo è l’accesso all’informazione (locale ed esterna) su qualunque supporto di registrazione, e così la biblioteca tende alla virtualità configurandosi sempre più come un intermediario dell’informazione, che offre all’utenza il documento e non solo la sua citazione bibliografica. Per quanto riguarda il futuro ruolo del bibliotecario a seguito dell’affermarsi di Internet, esso è legato a due "pericolosi" fenomeni: la cosiddetta disintermediazione ed il problema del sovraccarico di informazione in rete (information overload). 1) la disintermediazione è l’eliminazione (o attenuazione) in ambiente elettronico reticolare di tutte o alcune delle figure che tradizionalmente fanno da filtro tra autore e lettore, la tendenza – da parte dell’utente finale – a raggiungere e utilizzare le informazioni senza nessun coinvolgimento da parte delle biblioteche, derivante dall’offerta commerciale di servizi informativi. Infatti, se le caratteristiche della società dell’informazione sono molto in sintonia con l’ottica di servizio tipica della biblioteca, da esse – grazie ad un’altra interpretazione che vede nell’informazione un business – deriva anche la grande "offensiva" commerciale con un’offerta di prodotti e servizi rivolti direttamente all’utente, personalizzabili e a prezzi competitivi (ad es. gli editori e i distributori di periodici elettronici, i fornitori di servizi elettronici di document delivery e quelli che sfruttano la tecnologia push). Tuttavia, questi sviluppi che sembrano tendere alla disintermediazione in ambito elettronico lanciano soprattutto una sfida stimolante al tradizionale servizio bibliotecario basato sulla carta stampata. Addirittura, alcuni sono dell’idea che il passaggio al modello ipertestuale della rete non conduca alla dis-intermediazione, ma porti piuttosto verso la iper-mediazione: i percorsi possibili si moltiplicano enormemente e quindi sono ancora più necessari criteri con cui ordinare Internet. E criteri d’ordine formale come quelli che bibliotecari e documentalisti sono abituati a maneggiare professionalmente acquistano, opportunamente aggiornati, enorme importanza. Con la tecnologia, insomma, i bibliotecari potrebbero gestire l’enorme e disparata quantità di informazioni disponibili mediando tra gli utenti e quello che Ted Nelson ha chiamato docuverso. 2) L’informazione presente in Internet 1. è dunque ingente, e in continuo aumento, ed infatti sono stati coniati i termini di infoglut (indigestione da informazione) e appunto di information overload. Inoltre, gran parte dell’informazione di rete 2. non è di qualità e 3. è spessissimo scarsamente strutturata: è appunto… informazione. Forse non è casuale il fatto che siano prevalse le espressioni "società dell’informazione" e "overload dell’informazione", e non "della conoscenza". La differenza tra informazioni/dati da una parte e conoscenza dall’altra sta nel fatto che l’informazione consiste di fatti, dati, immagini e brevi testi staccati che possono essere utilizzati da soli; la conoscenza documentata, invece, è complessa, sequenziale e discorsiva, il contesto di ogni sua parte è un elemento essenziale. L’informazione si presta particolarmente ad essere immagazzinata attraverso mezzi elettronici. Ebbene la rete è soprattutto informazione, raramente conoscenza. Queste tre caratteristiche dei documenti che troviamo in Internet fanno sì che questa necessiti urgentemente di filtratori e organizzatori. Oggi chiunque abbia esaminato i pletorici risultati dei motori di ricerca ne ha fatto esperienza: il singolo individuo non riesce da solo a far fronte a questo sovraccarico di informazione elettronica (sia per mancanza di tempo, sia per mancanza di una adeguata formazione professionale). Visto che le soluzioni di natura informatica sono risultate fallimentari, non sarà dunque il caso di far uso di professionalità tipicamente umane? Ormai molti si stanno accorgendo della necessità di strumenti adeguati (bibliografie, cataloghi, repertori, indici) e di professionisti capaci di usarli e prepararli (bibliografi, documentalisti, indicizzatori, specialisti dell’informazione, bibliotecari), problemi di cui da secoli i bibliotecari si occupano. In particolare, dividendo lo spazio dell’informazione disponibile in Internet nel sottoinsieme delle risorse gratuite e in quello delle risorse commerciali possiamo corrispondentemente individuare due ruoli diversi per il professionista dell’informazione: cybrarian e information broker/manager. a) cybrarian (colui che padroneggerà le tecnologie e la mappa dell’informazione in rete): i bibliotecari hanno il bagaglio professionale giusto, in quanto da sempre abituati a trattare l’informazione basandosi sui bisogni dei loro utenti. Infatti, a parte il problema di servire l’utente "invisibile e remoto", il bibliotecario potrebbe porsi come "filtro" tra la propria utenza e l’universo informativo rappresentato dalla rete: selezionando, valutando la qualità e organizzando le risorse presenti in Internet basandosi sulla mission della biblioteca in questione, cioè sugli interessi della propria utenza. Se probabilmente il catalogo dei cataloghi non esisterà mai, la medicina contro l'information overload può consistere proprio in un passaggio dal grande al piccolo, capace di fornire un prerequisito di selezione e validazione di cui l'utente disintermediato sembra manifestare sempre di più l'esigenza. b) information manager: nella catena documentaria sono molti gli agenti che propongono servizi e prodotti informativi, ma l’utente al solito non è in condizione di valutare le varie offerte. Nel contesto dell’informazione elettronica commerciale, per il professionista dell’informazione nasce così l’opportunità di porsi come consulente in grado di valutare l’offerta di nuovi servizi informativi. Ma c’è di più: a parere di molti nell’era dell’informazione globale la nuova frontiera del lavoro del bibliotecario – soprattutto universitario – si chiama knowledge management. Secondo questo il ruolo che più di ogni altro compete al bibliotecario è quello di vero e proprio "produttore dell'informazione": e ciò non solo o non tanto perché è in grado di sviluppare raffinati strumenti e mappe informative, quanto perché, sempre più spesso, è chiamato a condividere con l'istituzione di cui fa parte la responsabilità della creazione – oltre che dell'ordinamento e della diffusione – delle conoscenze. Così la biblioteca viene introdotta all'inizio del ciclo di trasferimento dell'informazione e non più alla fine, e i bibliotecari sono implicati nel processo di produzione delle informazioni, e non soltanto nella loro gestione e distribuzione. Difatti, mentre in passato il compito del bibliotecario era quello di individuare e acquisire i documenti rilevanti – intervenendo quindi in una fase avanzata del processo di comunicazione scientifica – ora il suo coinvolgimento avviene in un primissimo stadio, ricevendo subito dai ricercatori i "dati grezzi" che costituiscono la base delle loro ricerche; a partire da tali dati, il bibliotecario costruisce un articolato sistema informativo, integrando le notizie in suo possesso con le fonti disponibili in loco e con quelle reperibili sulle reti; al termine del processo, rinvia questo ampio ventaglio d'informazioni ai ricercatori, che lo utilizzano per approfondire l'indagine e per tradurne i risultati in una pubblicazione. Si tratta di un ruolo ancor più attivo per i bibliotecari, in cui la biblioteca costruisce e mantiene delle basi di conoscenza specializzata in collaborazione con scienziati e studiosi: la banca dati del genoma umano è un notevole esempio di una tale collaborazione tra bibliotecari e ricercatori. Nel processo di comunicazione accademica – ma anche nelle biblioteche speciali/aziendali – il compito del bibliotecario sarebbe quello di arricchire di valore aggiunto le risorse elettroniche tramite i processi di valutazione, selezione e catalogazione consueti, di editing e assemblamento. Le spinte verso la disintermediazione, insomma, si possono combattere, soprattutto in questi ambiti accademici e specialistici. Anzi si direbbe che il ruolo del bibliotecario sia volto a un costante rafforzamento. Le sue funzioni – nuove e tradizionali al tempo stesso –lo trasformano addirittura in un protagonista della società dell'informazione. Oltre alla funzione di educazione dell’utenza, per evitare che il sovraccarico informativo schiacci l'utente e lo allontani dalle risorse effettivamente rilevanti, è indispensabile che il bibliotecario proceda ad una vera e propria "validazione" delle fonti sulla base di una loro accurata selezione e organizzazione: in tal modo è possibile offrire agli utenti una serie di percorsi di ricerca. La figura ed il ruolo del Bibliotecario-Documentalista Medico Uno dei problemi dei centri di documentazione clinica ospedaliera , quindi del Servizio Sanitario Nazionale riguarda la mancanza di riconoscimento giuridico della figura del bibliotecario/documentalista. Il quadro normativo che regola il settore può essere schematicamente riassunto come segue: D.P.R. 12.2.1968 n.132 - art. 19 Annovera tra i requisiti degli ospedali la "biblioteca e sala di riunione per sanitari". D.P.R. 27.3.1969 n.128 - art. 2 Attribuisce alla direzione sanitaria il compito dell’istituzione e del funzionamento delle biblioteche mediche L. 23.12.1978 n. 833 art. 2 - Annovera tra gli obiettivi fondamentali del SSN la formazione professionale nonché l’aggiornamento culturale del personale del SSN. art.17 - Sancisce l’appartenenza degli ospedali alle USL. D.M.P.I 9.11.1982 Fissa i requisiti di idoneità necessari alle USL, affinché le facoltà di Medicina possano utilizzarle ai fini della ricerca e dell’insegnamento e stabilisce che quale primo requisito i presidi o Servizi Ospedalieri "devono essere dotati o poter usufruire dei servizi generali di Biblioteca". D.P.R. 25.6.1983 n. 348 - art. 19 Assegna l’8% del finanziamento concesso dal Fondo Sanitario Nazionale per acquisire testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico, nonché tecnologie audiovisive ed informatiche. D.P.R. 20.4.1987 n.270 - art. 26 Ribadisce l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale, il suo finanziamento e riconferma che questo comprende anche l’uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale". CCNL Comparto Sanità 1998-2001 del 7 aprile 1999 - art. 29, c.7 "L’aggiornamento obbligatorio stabilito dall’azienda o ente è svolto in orario di lavoro e riguarda anche: l’uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale". Come si può notare anche nell’ambito dell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 1998-2001 del Comparto Sanità, siglato dalle parti il 7 aprile u.s., non esiste alcun riferimento alla figura del bibliotecario/documentalista. Tenendo conto di tutti i riferimenti legislativi sopra riportati è possibile desumere che: 1. le biblioteche nel SSN sono ritenute essenziali, ma non obbligatorie, senza, però, alcuna ulteriore indicazione sulle loro caratteristiche, funzioni e attività;
Fantasiose e varie sono, infatti, le qualifiche del personale delle biblioteche: ad es. vigilatrice d’infanzia, ausiliario, infermiere professionale, impiegato di concetto. Bibliografia. T. GIORDANO, Biblioteche digitali: la nuova frontiera della cooperazione, "Bollettino AIB", vol. 38 (1998), 3, p. 269-273, http://www.aib.it/aib/boll/1998/98-3-269.htm Cfr. R. RIDI, F. METITIERI, Le ricerche bibliografiche in Internet, Milano, Apogeo, 1998, pp. 192-193 C. BASILI, Dalla biblioteca meccanizzata alla biblioteca virtuale, "Biblioteche oggi", 15 (1997), ottobre, p. 30-35 RIDI, Dal canone alla rete, "Biblioteche oggi", 16 (1998), giugno, p. 12-19 M. GORMAN, Il futuro della catalogazione nell’era elettronica, "Bollettino AIB", vol. 38 (1998), 2, p. 139-147 BASILI, Verso la Società dell’informazione, "Biblioteche oggi", 16 (1998), luglio-agosto, p. 50-53 Cfr. RIDI, Il ruolo del bibliotecario nella società dell’informazione elettronica reticolare, in Il futuro è arrivato troppo presto? Internet, biblioteche ed accesso alle risorse informative. Atti del convegno di studi, Cagliari, 14-15 novembre 1996, a cura di P. Mascia e B. Orrù, Roma, AIB, p. 51-57 G. GATTI, Macchine celibi? Accumulo o distribuzione dell'informazione fra tecnologie e professionalità. Atti del Seminario "Il Presente Rinnovato". Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Bologna, 20 febbraio 1997, "Biblioteche oggi", 15 (1997), luglio-agosto, p. 6-21. Cfr. ad es. M. SANTORO, Biblioteche domani: il mutamento delle prospettive bibliotecarie all'alba del terzo millennio, "Bollettino AIB", (1998), 3, p. 303-322 S. M. MALINCONICO, Biblioteche virtuali, bibliotecari reali. Bibliotecario nel 2000, "Biblioteche oggi", 16 (1998), maggio, p. 12-20
|
|||
| Dagli atti del II^ Corso-Convegno:
"Internet ed Information Technology in Medicina". Ospedale di Legnago (Verona), 18 dicembre 1999. Pubblicazione
su "E-Neuro": 30 dicembre 1999
|