
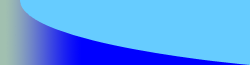
 |
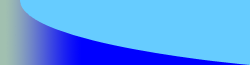 |
Il contributo prezioso della Neuropsicologia Clinica(come orientarsi tra tests e una difficile terminologia) Dr. Alec Vestri D.ssa Vanessa RaimondiDr. Renzo BassiLaboratorio di Neuropsicologia della Unità di Valutazione Alzheimer e altre Demenze Unità Operativa di Neurologia dell’ASL 22 - Bussolengo |
|||||||||||||||||||||||
|
La neuropsicologia clinica si occupa del rapporto tra mente e cervello e quindi dell'espressione comportamentale delle funzioni e disfunzioni cerebrali. E' di grande aiuto per i problemi pratici inerenti l'identificazione, la valutazione, l'assistenza ed il trattamento dei pazienti con lesioni cerebrali che determinano disturbi della attività mentale e del comportamento ; si avvale dell'esecuzione di Test Neuropsicologici, utilizzati soprattutto per lo studio delle funzioni cognitive. Per funzioni cognitive si intendono tutte le funzioni regolate dal sistema nervoso centrale che hanno a che fare con la ricezione, la ritenzione, l'organizzazione e la produzione di informazioni. Si parla di capacità percettive, mnestiche, di apprendimento, di attenzione, di produzione e comprensione verbale, di funzioni esecutive. L'attività cognitiva venne originariamente attribuita ad una singola funzione, l'intelligenza. I primi studiosi trattarono questo concetto come se fosse una variabile unitaria che aumentava a ritmo regolare nel corso dello sviluppo infantile normale e diminuiva con la quantità di tessuto cerebrale perso nel corso di una malattia o di un incidente. Quando l'affinarsi delle tecniche di valutazione e di gestione dei dati ha permesso una maggiore precisione, è stato evidente che la maggior parte del comportamento che i test di intelligenza misurano è direttamente riferibile a specifiche funzioni cognitive. Punteggi globali come il QI (Quoziente di Intelligenza) non portano ad una relazione diretta prevedibile con la dimensione delle lesioni cerebrali, in particolare per quanto riguarda i deficit non estremamente gravi. Le lesioni che coinvolgono una porzione della corteccia cerebrale usualmente alterano alcune funzioni mentre ne risparmiano altre. Una simile diseguaglianza è vista tipicamente negli effetti di una malattia cerebrale di tipo degenerativo dove non solo alcune funzioni sono compromesse negli stadi precoci mentre altre possono mantenersi relativamente intatte per anni, ma anche le funzioni coinvolte si deteriorano con ritmi differenti. Un deterioramento differente a carico di diverse funzioni psicologiche compare anche nell'invecchiamento. In breve gli studi neuropsicologici hanno dimostrato che non esiste una funzione generale cognitiva o intellettiva, ma esistono alcune funzioni discrete, che costituiscono una classe distinta di comportamenti, ma che operano insieme in accordo stretto e interdipendente. Ognuna delle funzioni corticali si suddivide in una serie di altre sottofunzioni le quali non sono sempre in rapporto subordinato rispetto alle principali, ma più spesso attraversano varie altre funzioni generali mettendo in evidenza come non è più plausibile pensare a un modello di sistema cognitivo basato su moduli distinti uno dall'altro, ma occorre pensare a un'intricata rete di collegamento di cui ogni funzione è interdipendente rispetto alle altre. In particolare, la memoria e l'apprendimento si riferiscono all'immagazzinamento, alla conservazione e al recupero dell'informazione. Alcune sottofunzioni della memoria sono la memoria anterograda (immagazzinamento di eventi successivi al momento della lesione delle aree corticali), memoria retrograda (conservazione e al recupero di eventi precedenti alla lesione delle aree corticali), memoria prospettica (ricordo che permette di pianificare gli impegni futuri) e ancora memoria dichiarativa di tipo episodico o semantico (precisi fatti accaduti o conoscenze che prescindono da episodi), memoria procedurale (relativa al "come si fa"), memoria spaziale (rapporti di distanze e di locazione degli oggetti presenti nel campo visivo), memoria topografica (orientamento geografico), memoria visiva (informazioni puramente visive anche prive di significato). Per far capire la complessità delle funzioni cognitive, va specificato che vi sono ulteriori sottotipi di memoria a seconda che vengano combinati tra loro o che entrino in gioco altre funzioni cognitive.
Nell'esame neuropsicologico è possibile valutare distintamente tali tipi di memoria ed evidenziarne le alterazioni. Anche le altre funzioni possono essere suddivise in ulteriori sottofunzioni, rendendo evidente l'estrema complessità del sistema. Si prenda ad esempio la funzione attentiva (preposta alla selezione delle informazioni utili a discapito delle informazioni non-utili): un calo di attenzione condiziona pesantemente le capacità di memorizzazione, tuttavia, un'ottima capacità di memoria può compensare un piccolo deficit di attenzione. Prima di effettuare l'esame neuropsicologico al paziente viene spiegato che esso serve per capire meglio come funziona il suo cervello, per valutare le sue capacità di ricordarsi informazioni appena acquisite, di apprendere informazioni nuove, di porre attenzione a singole attività in momenti diversi, oppure a diverse attività nello stesso momento, di comprendere quello che ci viene detto, di pianificare una sequenza di attività, di risolvere dei problemi, di ragionamento, di astrazione. Vengono poste domande sulla capacità dei pazienti di utilizzare le proprie competenze e l'autogestione, l'attendibilità nel seguire un regime terapeutico, di comprendere il valore del denaro, che sono alla base dell' autonomia personale. Una batteria di valutazione neuropsicologica è un insieme di test che misurano specificamente e selettivamente alcune funzioni cognitive, le principali, le più facilmente coinvolte in processi lesivi o di deterioramento. Un esame generale permette di evidenziare dei deficit per grosse aree o dei sospetti per sotto-aree. Ogni esame può essere approfondito per sottoaree, una volta che sono stati evidenziati dei sospetti. L'esame neuropsicologico non costituisce semplicemente una elencazione di risultati di test di funzioni cognitive, ma si completa di un parere tecnico dato da una persona esperta di processi cognitivi e di fattori psicologici,. Quando tutti i dati sono raccolti esaurientemente, l'esaminatore dovrebbe avere una comprensione realistica di come il paziente reagisce ai deficit e può compensarli al meglio e della possibilità e della modalità di intraprendere con profitto la eventuale rieducazione. I fattori psicologici sono fondamentali per comprendere come le funzioni cognitive si inseriscono nel quadro generale di vita della persona: vi sono infatti atteggiamenti, stili cognitivi, pensieri, emozioni, situazioni di vita, che condizionano pesantemente le capacità cognitive e solo lo psicologo esperto può riuscire a valutare tutti i fattori in gioco. La valutazione neuropsicologica può risultare utile nel discriminare tra sintomi psichiatrici e neurologici, nell'identificare un possibile disturbo neurologico in un paziente non psichiatrico, nell'aiutare a distinguere tra differenti condizioni neurologiche e nel fornire dati per la localizzazione della sede di una lesione; aiuta anche a definire in quale emisfero si trovi (una diagnosi accurata si fa con altri strumenti). I dati neuropsicologici inoltre possono fornire indici sensibili del livello a cui i trattamenti farmacologici rafforzano o compromettono l'efficienza mentale di un paziente. Un'altra applicazione della neuropsicologia clinica si ha nella riabilitazione per le lesioni cerebrali organiche; fra le Unità ad Alta Specialità di Riabilitazione, nel piano Sanitario Nazionale, è da citare l'istituzione delle Unità di Riabilitazione per turbe Neuropsicologiche Acquisite (URNA), che si affiancano ad altre unità di approccio multidisciplinare nell'ottica di una visione globale dei bisogni di riabilitazione dei pazienti post-acuti con deficit multipli. Attualmente il lavoro dei neuropsicologi è assorbito dall'ampio capitolo dei deterioramenti mentali nelle persone anziane. L'impatto di questa estesa patologia ha suscitato molta attenzione e stimolato alcune inziative, di cui la più rilevante il progetto Cronos, che prevede sempre un esame neuropsicologico e ha stimolato nuovi approcci di tipo sociale e riabilitativo per gruppi di pazienti con deterioramento cognitivo. La documentazione e quantificazione dei deficit cognitivi risulta essenziale sia nella definizione e monitoraggio dell'andamento dei deficit mentali, che nella distinzione fra sindromi cognitive e sindromi psichiatriche, che nella valutazione delle potenzialità residue delle persone. Uno degli aspetti più interessanti nello studio delle demenze è la possibilità di effettuare una diagnosi differenziale tra invecchiamento normale e patologico. Il deterioramento cognitivo cronico progressivo identifica un invecchiamento patologico cioè la conseguenza comportamentale di una patologia acquisita da un cervello che prima funzionava normalmente. Caratteristica base è l'andamento evolutivo sistematicamente peggiorativo dimostrabile nell'arco di almeno 6-12 mesi (progressività). Molteplici difetti di natura neuropsicologica interagiscono dando luogo al deterioramento cognitivo; inoltre tale quadro si completa con l'incompetenza nella gestione del quotidiano e l'incongruenza di alcuni comportamenti del paziente rispetto alla situazione sociale e delle aspettative di chi lo circonda. I sintomi d'esordio della demenza sono spesso di natura mnestica e frequentemente sono giustificati dall'avanzare dell'età, ma un lento e progressivo peggioramento, episodi di disorientamento spaziale o temporale, riconoscimenti mancati di persone ed eccessive confusioni, devono indurre a sottoporsi a degli accertamenti. In questa evenienza è indispensabile una valutazione neuropsicologica approfondita e normalmente non è sufficiente un test di screening come il Mini Mental Status Examination (MMSE) anche se è utile strumento di valutazione molto generale, veloce e semplice da eseguire. Questo strumento permette di avere delle indicazioni sull'orientamento temporale e spaziale del paziente (si domanda al pz dove si trova e qual è la data odierna), sulla sua capacità di ripetere delle parole, di ricordarle, di fare semplici ragionamenti, di riconoscere degli oggetti, di eseguire semplici ordini, di scrivere una frase o copiare un disegno. Il punteggio totale è 30; indicativamente si considera nella norma da 30 a 24, da 23 a 18 si parla di un deficit lieve, da 17 a 11 di un deficit medio, da 10 a 0 un deficit grave. Se eseguito in maniera corretta, permette già al medico di base di fare una buona selezione. Il neuropsicologo deve valutare anche gli aspetti psicologici clinici e psicopatologici (pseudodemenza) che possono diventare concause del decadimento mentale e non meramente cause primarie o effetti secondari dello stesso, in particolare nei pazienti con problemi psichiatrici. La neuropsicologia valuta efficacemente il disturbo comportamentale. Nel decorso delle demenze, nel 90% dei casi si manifestano anche sintomi non propriamente cognitivi. Anche Alois Alzheimer nel lavoro del 1907 descrisse il caso di una donna di 51 anni che aveva sviluppato sia declino cognitivo che sintomi psichiatrici e in particolare depressione e deliri persecutori e di gelosia. La presenza di sintomi non cognitivi va valutata con particolare attenzione, sia per la rilevanza dal punto di vista diagnostico, che per l'impatto sulla qualità di vita del paziente e della famiglia. Tali disturbi, che possono essere presenti già nelle prime fasi della malattia, sono eterogenei, fluttuanti e influenzabili da variabili somatiche e ambientali. Attualmente si ritiene che i sintomi non cognitivi rappresentino una manifestazione primaria delle anormalità neuropatologiche e neurobiologiche della demenza, sebbene siano fortemente influenzati dall'ambiente e siano legati alla personalità premorbosa dell'individuo. Potremo osservare Sintomi Psicotici come deliri, paranoidei nel 45% dei casi (gelosia, persecuzione), misidentificazioni e nel 10% dei casi, allucinazioni, per lo più visive o Alterazioni dell'umore come ansia nel 50% dei dementi, nel 30-50% sintomi depressivi, nel 5-8% euforia e nel 40% labilità emotiva, Alterazioni della personalità: apatia nel 70% , irritabilità nel 40% e disinibizione nel 39% circa , Agitazione: presente nel 60% dei casi, va dall'aggressività verbale o fisica alla vocalizzazione persistente, Disturbi dell'attività psicomotoria : presenti nel 40% circa dei casi, con vagabondaggio e affacendamento afinalistico e Sintomi neurovegetativi : alterazioni del ritmo sonno-veglia, dell'appetito e del comportamento sessuale Recentemente la Regione Veneto ha stanziato dei fondi per dare un contributo economico a favore delle famiglie che assistono persone con demenza associata a gravi disturbi del comportamento. Presso l'ospedale di Bussolengo, dove l'ambulatorio di neuropsicologia opera dal febbraio 2000, è stato applicato il Neuropsychiatric Personalità Inventory (NPI) un intervista semistrutturata rivolta al familiare necessaria per la richiesta del contributo economico, uno degli appositi strumenti neuropsicologici che permette di valutare e quantificare anche l'aspetto comportamentale. Nel primi due mesi (settembre-ottobre) presso l'ambulatorio di neuropsicologia sono state così esaminate ben 150 persone, provenienti da diversi distretti. Questa iniziativa della Regione nasce dalla consapevolezza del grave carico del familiare di un malato di demenza di Alzheimer sia sul piano economico che psicologico. Il malato nella fase più avanzata diventa spesso un'altra persona, non parla, è apatico, indifferente, magari irriverente o poco riconoscente, a volte nervoso e opponente; spesso i familiari devono rinunciare alla propria vita privata e sociale. Il (neuro)psicologo, sa valutare questi aspetti e può dare utili indicazioni ai familiari che hanno un carico emotivo terrificante e hanno bisogno di conoscere in dettaglio lo scenario della evoluzione della malattia con le ripercussione psicologiche e sociali conseguenti. Il lavoro svolto nel nostro laboratorio di neuropsicologia consiste di 4 momenti fondamentali:
I protocolli di terapia sperimentale gratuita del progetto nazionale Cronos richiedono una valutazione approfondita delle funzioni cognitive che attesti un deterioramento mentale compatibile con i criteri sintomatologici del morbo di Alzheimer. A tale fine si utilizza una batteria di test concordata ed adattata assieme alle altre UVA. L'esperienza maturata in tre anni, su un campione di più di 600 esami, ha permesso di validare l'utilità ( anche predittiva della evoluzione dei disturbi) dei test usati e ci ha fatto scoprire che molti pazienti anziani mostrano deterioramenti cognitivi diversi dalla forma di Alzheimer, come poteva sembrare in prima battuta. InoItre i nostri dati mettono in luce la frequente compresenza di disturbi psichiatrici in patologie cerebrali degenerative. Vi sono pazienti con marginali o rilevanti disturbi del comportamento in conseguenza dell'impoverimento del funzionamento cognitivo, ma ve ne sono altri con veri e propri sintomi psichiatrici concomitanti ai deficit cognitivi. Circa il 34% (58 su 169) dei pazienti con referto che indica deterioramento cognitivo manifesta anche concomitanti aspetti psicologici o psichiatrici di una certa rilevanza: i più comuni sono il tono dell'umore marcatamente depressivo, ma molto spesso vi sono difficoltà di collaborazione e irritabilità, inoltre vi sono anche spunti di tipo paranoideo, ossessivo e ipocondriaco e frequentissimi disturbi d'ansia. C'è stato nel tempo un incremento della richiesta dell'esame neuropsicologico, oltre che da neurologi e geriatri, da parte della Commissione Invalidi (dal 9 al 17%) e da parte dei medici di base (dal 2 al 14%). Non raramente i pazienti inviati presentavano un quadro di deterioramento cognitivo talmente grave da non rendere possibile la somministrazione di molti test di base (o comunque la valutazione neuropsicologica non avrebbe aggiunto alcuna informazione utile) per cui conviene escludere dalla richiesta di tale esame tutti quei pazienti che riportano un MMSE (gestibile anche da non specialisti) minore di 10. Ciò a meno che il basso punteggio non sia dovuto ad un evidente deficit di altro tipo (per esempio sensoriale, motorio o anche una grave compromissione della produzione di parole, come un'afasia).
|
|||||||||||||||||||||||